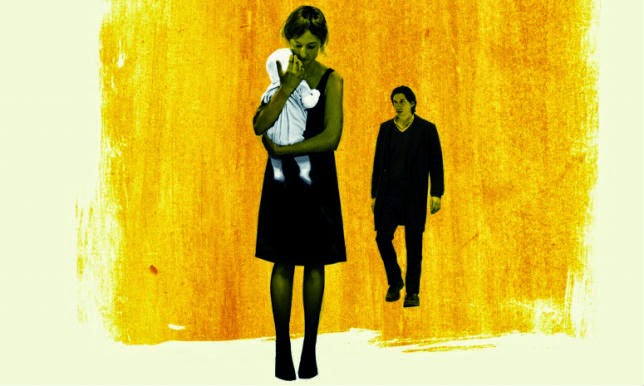Quando ero ragazza c'è stato un momento nel quale mi sono sentita così vicina ai miei amici, così integrata nel cerchio dei nostri affetti reciproci, che pensavo che la trasparenza dei nostri pensieri e delle nostre anime, la completa condivisione di emozioni, desideri e paure, non fosse altro che una splendida opportunità.
Tra persone che si amano e si rispettano, pensavamo e dicevamo e cercavamo di mettere in pratica, non c'è niente di più bello che condividere.
I social network non esistevano ancora, ma noi passavamo insieme molto tempo a parlare e discutere sulle nostre letture, i film, lo studio, le amicizie, la famiglia, insomma su tutto quello che è la vita di un adolescente. Era bello pensare che non c'erano filtri tra noi, che tutto poteva essere affrontato, anche quando si trattava di emozioni come la gelosia o la competizione o la vergogna. Fu il momento nel quale aprii i miei diari segreti, anche le pagine degli sfoghi più puri, alle lettura dei miei amici, convinta che potevano sapere e comprendere.
Il libro di Dave Eggers Il Cerchio mi ricorda quel periodo.
Racconta di un futuro molto vicino nel quale i rapporti umani sono ormai del tutto condizionati da un'unico social network privato, il Cerchio appunto, al quale tutti sono connessi, non solo per il loro divertimento, ma per lavorare, per gestire la sicurezza del proprio quartiere, alla fine addirittura per votare. Le videocamere funzionano a energia solare, sono sempre attive e ovunque, possono prevenire colpi di stato (vedi quello che è successo stanotte in Turchia), possono dissuadere dal compiere atti criminali.
Il Cerchio ha bandito l'anonimato degli account e emarginato i troll e coloro che nascondevano la propria identità, è in grado di rintracciare ogni evento significativo della vita dei singoli e tiene costantemente aggiornate le classifiche degli smile e dei frown per ogni profilo, per ogni attività. Gli slogan inneggiano ad una totale trasparenza: i segreti sono bugie, solo condividendo ogni angolo della propria esperienza ci si può prendere cura uno dell'altro, e se non si è disposti a farlo si commette una trasgressione nei confronti della società.
Non è difficile immaginare che questo conduca ad una forma di controllo totalitario. Mi sono preoccupata perchè, proprio in questi giorni, Google mi sta chiedendo se può unire i dati del mio blog con quelli dell'account Google + , non è così inverosimile che già abbia chiaro un quadro delle ricerche e anche dei miei post pubblici su FB.
Eggers a mio avviso è geniale nel rappresentare il modo in cui a questo controllo totalitario ci stiamo tutti sottoponendo in modo volontario, coltivando una ideologia della trasparenza della quale non si notano i limiti e i vincoli. Descrive, attraverso una protagonista che sale progressivamente nella gerarchia del network fino a diventarne l'immagine di punta, il modo nel quale tutto questo processo possa essere convincente e condurre ad una adesione quasi universale.
In una delle scene più coinvolgenti, uno dei soci fondatori del Cerchio intervista la protagonista che ha commesso una lieve infrazione, documentata da una delle videocamere del network. Vuole dimostrare che la trasparenza "panoptica" è l'unica strada percorribile e indurla ad indossare una videocamera che riprenda e trasmetta in tempo reale ogni sua giornata. Mae si fa convincere: aderire ad un gruppo che pensa di essere sempre dalla parte della ragione, che esalta i successi e sembra perdonare gli errori (a patto che vengano riconosciuti ed espiati) rende sicuri e fa sentire amati.
Per questo mi sono ricordata del nostro periodo "totalitario", che in realtà ebbe una fine abbastanza rapida, e passammo dal gruppo come unica fonte di riconoscimento a dinamiche conflittuali. Non ho più fatto leggere i miei diari.
Secondo alcuni autori della psicoanalisi interpersonale (Fonagy Target 1996) la capacità di riflettere sulla propria mente nasce nel momento in cui siamo capaci di nascondere una parte di noi, dei nostri pensieri, alla mente degli altri. Il bambino comprende che tutti abbiamo una mente quando comincia a raccontare bugie, per cui si accorge che la madre non ha il potere di sapere se lui sta mentendo. Il segreto e la bugia, così come il gioco e la finzione, hanno un valore evolutivo, possono essere la base del primo modo di riflettere su se stessi. Quindi della nostra identità.
Se la trasparenza diventa la regola la mia identità viene cancellata.
Ma se l'ideologia della trasparenza prende il sopravvento, in nome della sicurezza, come sta ad esempio avvenendo di fronte al terrorismo, se cerco di nascondermi, se mantengo privato il mio mondo di pensieri ed emozioni, divento un sospetto.
C'è una idea "geniale" nel libro che proporrei ai politici del M5S: indossare sempre una videocamera, per documentare la purezza di ogni contatto con i colleghi, con i cittadini e con eventuali sponsor che volessero avvicinarli per corromperli. Proverebbero irrefutabilmente di essere diversi da tutti gli altri partiti. Nel libro di Eggers alla fine tutti i politici si piegano a questa innovazione. Chissà se non ci hanno già pensato alla Casaleggio SPA.
Visualizzazione post con etichetta psicologia. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta psicologia. Mostra tutti i post
sabato 16 luglio 2016
lunedì 7 marzo 2016
Tutte le famiglie si somigliano?
Ci sono ancora persone
che pensano e dicono che le coppie omosessuali che vogliono crescere
dei figli sono “contro natura”, Alfano non è l'unico, i social
media sono pieni di commenti simili in questi giorni.
Al di là della banale
considerazione che la famiglia non è un dato naturale, ma una
espressione sociale e culturale, una forma antropologica, l'idea che
delle coppie omosessuali non possano essere dei buoni genitori
risulta un tema di riflessione particolarmente intrigante per una
psicologa come me, che lavora con bambini e genitori, tutti i giorni,
da molti anni.
Essere figli e diventare
genitori (o scegliere di non esserlo) sono esperienze universali e
particolari allo stesso tempo: perchè riguardano tutti, ma poi
ognuno ha come riferimento la propria singola esperienza.
In qualche modo questo
tema appassiona perchè tocca da vicino qualcosa che crediamo di
conoscere molto bene, qualcosa su cui ci sentiamo a priori degli
esperti.
 Questo è così vero che
ogni volta che ho visto citare gli studi psicologici che documentano
che lo sviluppo psicosessuale dei figli in famiglie omogenitoriali
non è sostanzialmente diverso da quello dei ragazzi cresciuti in
famiglie eterosessuali, studi che non trovano differenze
significative né per quello che riguarda l'orientamento sessuale, né
per l'identità di genere (1), questo argomento viene alla fine
semplicemente ignorato oppure trattato come un dato relativo.
Questo è così vero che
ogni volta che ho visto citare gli studi psicologici che documentano
che lo sviluppo psicosessuale dei figli in famiglie omogenitoriali
non è sostanzialmente diverso da quello dei ragazzi cresciuti in
famiglie eterosessuali, studi che non trovano differenze
significative né per quello che riguarda l'orientamento sessuale, né
per l'identità di genere (1), questo argomento viene alla fine
semplicemente ignorato oppure trattato come un dato relativo.
Nelle opinioni risulta
molto più forte e importante il riferimento alla propria esperienza:
“io so che se fossi cresciuto da due omosessuali (in base al
pregiudizio che ho nei loro confronti) mi sarei trovato male, mi
sarebbe mancata la mamma oppure il papà”.
In modo molto evidente,
nelle foto e negli slogan sui social media, emerge quanto il vero
punto della discussione sia l'impossibilità di concepire che possa
esserci un altro modo di essere figli o genitori. Vale lo stesso
principio per cui se sono cresciuto con una morale rigida sui
rapporti prematrimoniali e non l'ho mai contestata, non concepirò
che i miei figli non crescano nello stesso modo o che mia moglie
possa avere una morale diversa.
Non serve quindi a quasi
niente ricordare ancora una volta gli studi che rilevano che oltre
il 90% dei figli di famiglie omogenitoriali ha un orientamento
eterosessuale, una percentuale sovrapponibile a quella dei figli
delle famiglie eterosessuali.
Si tende a usare
“naturale” come sinonimo di ciò che ci è stato trasmesso, senza
che ci sia bisogno di spiegazioni e pensiero critico, ciò che
assimiliamo all'interno di relazioni importanti e fondanti la nostra
stessa identità.
Uno dei training
fondamentali per diventare psicologo clinico e psicoterapeuta
consiste nella ricostruzione della propria storia personale e
familiare attraverso il confronto critico con uno psicoanalista, uno
psicoterapeuta o un gruppo di pari che analizzano insieme il proprio
“genogramma”. Chi si trova a doversi confrontare infatti con le
patologie delle relazioni familiari o con la sofferenza mentale del
singolo ha bisogno di vedere da una prospettiva critica prima di
tutto la propria storia, per non assolutizzarla e non farla diventare
il metro con la quale giudicare quella degli altri.
Non so come sia possibile
far sperimentare lo stesso decentramento a chi sostiene con tanto
vigore e furore propagandistico che non può esistere altra famiglia
oltre a quella che lui stesso ha conosciuto.
Spesso le convinzioni ed
i pregiudizi sociali cominciano a modificarsi solo nella estensione
del fenomeno, solo quando cominceremo a conoscere davvero figli
cresciuti da coppie omogenitoriali e ci troveremo a conversare, fuori
dalla scuola, aspettando i pargoli nel giardino, con il papà o la
mamma della coppia che prima guardavamo con sospetto e scopriremo che
hanno le stesse nostre esperienze, le stesse paure, le stesse
emozioni.
Forse semplicemente dovrà
succedere che nostro figlio ci confessi che ama un uomo e che
vorrebbe avere un figlio oppure che nostra figlia si innamori di un
ragazzo cresciuto da due mamme.
 Poco meno di 40 anni fa
anche chi era contrario al divorzio sosteneva che i figli dei
genitori divorziati erano destinati ad essere tutti sofferenti.
Mentre i fattori che influenzano la serenità dei figli sono molti e
presenti sia nelle coppie sposate che separate: ad esempio il livello
di conflittualità espressa o repressa tra i genitori, oppure la
depressione o un altro disturbo psicopatologico, ma non la
separazione in sé.
Poco meno di 40 anni fa
anche chi era contrario al divorzio sosteneva che i figli dei
genitori divorziati erano destinati ad essere tutti sofferenti.
Mentre i fattori che influenzano la serenità dei figli sono molti e
presenti sia nelle coppie sposate che separate: ad esempio il livello
di conflittualità espressa o repressa tra i genitori, oppure la
depressione o un altro disturbo psicopatologico, ma non la
separazione in sé.
Anche per l'aborto ci fu
una forte mobilitazione contraria e molti fecero previsioni
catastrofiche sull'uso che le donne ne avrebbero fatto. Invece il
numero di aborti è costantemente diminuito e si è dimezzato
rispetto ai primi anni dall'approvazione della legge 194/78. Secondo
il rapporto del Ministero della Salute del 2013 in Italia abbiamo uno
dei tassi di interruzione di gravidanza più bassi tra quelli dei
paesi industrializzati.
I cambiamenti del costume
sociale non saranno ostacolati dalle opinioni di chi cerca di
conservare ciò che appare “naturale” solo perchè è
consuetudine, i cambiamenti avverranno comunque, è bene quindi che
il legislatore possa intervenire per regolamentare le nuove relazioni
sociali che si creano. Vietare o non riconoscere alcuni diritti, che
corrispondono a una diversa tipologia di relazione familiare, non
serve e alla lunga crea solo ulteriori disfunzioni e ingiustizie.
Invece regolamentare aiuta a definire meglio i limiti e le
responsabilità dei singoli verso il corpo sociale.
E' una realtà sociale
l'esistenza di coppie di donne che hanno avuto un figlio ed è il
figlio a soffrire della mancanza del diritto di essere accudito da
una delle sue mamme.
E' anche una realtà che
il fattore che ostacola sia lo sviluppo dei figli di coppie
divorziate, sia le donne che si assumono la responsabilità di un
aborto, sia i bambini che vivono con coppie omogenitoriali è
rappresentato dallo stigma sociale. L'intolleranza, il giudizio
morale, la discriminazione rappresentano i veri fattori di rischio di
un sano sviluppo.
La famiglia è una
costruzione sociale e culturale, così come l'idea di maternità o di
paternità. Ha dei vincoli biologici che sono determinanti per lo
sviluppo dell'individuo, ma altrettanto determinante è il
significato psicologico individuale, sociale e culturale che viene
dato al vincolo biologico. (Tra parentesi gli studi di gender si
occupano di approfondire le variabili implicate nella definizione di
maschio o femmina, non sono una ideologia, ma un campo di teorie e
osservazioni molto complesso).
Un grande scrittore
diversi anni fa sosteneva che tutte le famiglie felici si somigliano,
mentre ogni famiglia infelice lo è a modo suo.
Però ogni storia
familiare può essere felice o infelice a modo suo, l'importante è
capire come lo è diventata, felice o infelice, non giudicarla in
base a norme e verità che probabilmente nessuno può detenere.
1 – 26 studi
esaminati da Prati e Pietrantoni (2008) sulla Rivista Sperimentale di
freniatria, 77 studi scientifici Individuati nell’ambito del
progetto Whatweknow della Columbia Law School di New York, 150 studi
presi in esame dal report Patterson (2005) presente sul sito della
American Psychological Association.
martedì 25 agosto 2015
Elena Ferrante e la smarginatura del femminile
Ci sono libri che toccano qualcosa di profondo in noi, che non si riesce subito a capire e ci vuole tempo per elaborare. Ho letto i quattro volumi de L'amica geniale, come faccio sempre quando una lettura mi appassiona, tutti di seguito, nel mese di maggio. Ho pensato di scrivere qualcosa, ma mi ci sono voluti mesi per rifletterci.
Intanto la Ferrante non ha vinto il premio Strega.
Intanto ho letto un altro libro di psicoanalisi infantile, Il dramma del bambino dotato, un libro di Alice Miller, psicoanalista controversa, che si è allontanata dalla società psicoanalitica in polemica sulla teoria dei traumi infantili, perchè sostiene che i bambini sono oggettivamente maltrattati, sia fisicamente che psicologicamente, e che questa è la radice del malessere sociale nel quale tutti viviamo. Mentre la psicoanalisi considera con cautela la realtà del trauma psichico, dando maggior spazio alle fantasie infantili ed alle angosce, considerate primarie, della nostra esistenza.
La Miller sostiene che le madri, in particolare, creano un rapporto patologico con i propri figli, un rapporto nel quale riversano il disprezzo, come una rivalsa delle ferite ricevute della loro infanzia.
Oppure le madri si vendicano nel rapporto con i figli del rinnovato dolore che suscita la trascuratezza o la violenza del compagno, anch'egli ferito, sempre, inevitabilmente, da una madre.
Anche le relazioni del romanzo de L'amica geniale sono relazioni piene di violenza, di rancori, di gelosie e invidie, di rispecchiamenti e di simbiosi malate.
Però sono colme di sentimenti e di creatività e di rivalse che possono ad un certo punto essere in qualche modo salvifiche. Ci sono traumi e tentativi di sollevarsi dal trauma, cadute e riscatti, incompiuti spesso. Ambivalenti spessissimo.
Lila scompare, non lascia tracce, non vuole essere trovata.
Allora Elena, Lenuccia, Lenù, scrive di lei, racconta la loro storia, la storia di una amicizia.
Nel leggere L'amica geniale si segue il filo del gioco doppio delle identità. Lenù si confronta con il suo doppio Lila, nata il suo stesso anno, nello stesso mese, che vive nello stesso quartiere. Giocano con le bambole e Lila le butta la sua in uno scantinato buio dell'orco del condominio. Come in una favola le bambine vanno a cercare la bambola e non trovandola Lila ha il coraggio di bussare alla porta dell'Orco, ma prima prende per mano Lenù.
Cerca il coraggio? Vuole consolarla e incoraggiarla?
Comincia il gioco di specchi tra le due amiche. Non si sa chi tra le due sia davvero l'amica geniale, l'amica che ha il Genius, l'ingegno, ma anche il demone che scombina le carte, che trasgredisce le regole.
Lila è coraggiosa, ma è anche cattiva, è capace di leggere e comprendere argomenti nuovi velocemente e in modo profondo, ma non porta a termine i suoi progetti e basta uno scatto di orgoglio ferito per buttare tutto all'aria. Lila la scarpara, la commerciante, la sposa invidiata, l'amante, l'operaria. la sindacalista, l'informatica. Lila che vuole solo non lasciare tracce, che critica il successo e spinge l'amica a trovare la sua strada.
Lila che ama, viene abbandonata e tradita. Lila che viene di nuovo adottata da un amante modesto, ma fedele, Enzo.
 Lenuccia ha una madre claudicante, che la controlla, la giudica e tenta di tenerla con lei, a scapito dei suo talento, una madre gelosa che si irrita per l'attenzione che la bambina suscita nella sua maestra, che le fa pesare i soldi per fare l'esame e passare alle scuole medie. L'esame che Lila non potrà fare.
Lenuccia ha una madre claudicante, che la controlla, la giudica e tenta di tenerla con lei, a scapito dei suo talento, una madre gelosa che si irrita per l'attenzione che la bambina suscita nella sua maestra, che le fa pesare i soldi per fare l'esame e passare alle scuole medie. L'esame che Lila non potrà fare.Lena non vuole essere come sua madre, si allontana da lei e da Napoli (e da Lila) alla ricerca di un riscatto attraverso la cultura e la scrittura.
Le madri sono davvero il motore di tutto? Sono la radice dei traumi e dei riscatti? Hanno la colpa di aver generato e la colpa di essersi aspettate qualcosa dal frutto del loro grembo?
"Io ti ho fatto ed io ti sfaccio" dicono a volte ai loro figli..
Lena lascerà le sue bambine insiema al marito, tradito per stare con il suo amore, inseguito per una vita, lo stesso che aveva tradito Lila. Anche la protagonista de I giorni dell'abbandono, altro racconto della Ferrante, vive i figli come un peso, un ostacolo, anche la professoressa de La figlia oscura lascia le figlie al marito.
Invece Lila "perde" la sua bambina, che scompare, forse rapita, forse uccisa. Un altro trauma della maternità. Madri che abbandonano, madri che soffocano, madri che cercano una soddisfazione nella vita delle figlie. Figlie che amano e detestano le proprie madri, che si allontanano, che scompaiono.
Entrambe le protagoniste sembrano rappresentare i conflitti dell'essere donne nella seconda metà del Novecento, la tensione verso la libertà dai ruoli della famiglia di origine, che si acquisisce solo
sposandosi, ma anche l'emancipazione attraverso lo studio, che porta Elena a conoscere il mondo del femminismo, mentre Lila si emancipa nel lavoro e nel ruolo di sindacalista. La difficoltà di conciliare il lavoro di cura dei figli con il proprio lavoro e le proprie ambizioni. Il tradimento più grande sembra quello di essere indipendente dall'obbligo della maternità e dalla seduzione
Non è facile riuscire a rendere l'intreccio di tutti questi piani e temi, che si snodano lungo i quattro romanzi della Ferrante: i due assi che si intersecano, della costruzione della identità femminile e quello delle relazioni madre-figlia, uomo-donna, sono interconnessi e mobili allo stesso tempo e attraversano varie storie collaterali.
La perdita dei margini, la smarginatura, l'esperienza che trasforma la realtà di ogni giorno in una mondo che si scioglie, perde consistenza e senso, simboleggia forse la difficoltà di creare una identità femminile, materna, individuale e sociale per le due amiche.
Daltronde anche Elena Ferrante non c'è, al di là della sua scrittura non esiste, non è vista. (e proprio per questo suo nascondersi all'ineluttabile commento mediatico sul suo aspetto, sulla sua vita privata, penso che sia una donna).
Quindi credo che avrebbe meritato di vincere il premio, lo Strega o un altro, perchè a differenza delle interpretazioni lineari che dà l'analista Miller, la Ferrante raccontando di donne si interroga sulle loro relazioni e sulla loro difficile identità di madri, spose, figlie, scrittrici, operarie, senza dare risposte, senza suggerire soluzioni, come ogni grande romanziere, che tenta di ricostruire la complessità della vita.
Per quello che riguarda me, invece, la riflessione che alla fine è emersa dalla lettura della Ferrante è che il compito più complesso è certamente riuscire ad amare i figli per quelli che sono e non per quello che vorremmo che fossero, ma soprattutto, da figlie adulte, ad amare le madri così come sono e non per quelle che vorremmo fossero state.
venerdì 17 aprile 2015
Meditazione mindfulness V. Per uscirne bisogna passarci in mezzo.
Ho finito di leggere un bel libro sulla meditazione, sul buddismo e la psichiatria, La lezione della serenità. L'autore è uno studioso, uno psichiatra statunitense, che è anche un buddista, Mark Epstein.
L'aspetto interessante della sua analisi è il tentativo di leggere la figura del Buddha ed il suo messaggio come il frutto della elaborazione del trauma della perdita della madre.
Tale elaborazione si compie attraverso gli anni nei quali il principe Siddharta ricerca una soluzione alla consapevolezza del dolore della esistenza, prova varie pratiche e filosofie ascetiche, ma alla fine sotto l'albero della Bodhi raggiunge l'illuminazione. Il ricordo di un momento di gioia della sua infanzia, un momento nel quale Siddharta sembra recuperare uno stato di unione con la madre perduta, dissociato dal momento del suo trauma, sembra essere la radice che permette di osservare e tollerare la sofferenza del mondo.
Il trauma provoca una dissociazione delle emozioni catastrofiche dallo stato di coscienza attuale. A volte anche alcuni stati primitivi di de-sincronizzazione nella relazione tra la madre ed il neonato, secondo alcune odierne scuole psicoanalitiche, possono provocare stati emotivi che vengono dissociati.
Seguendo uno studioso, lo psicoanalista Philip Bromberg, autore di Clinica del trauma e della dissociazione, si potrebbe dire che il modello che il Buddha propone come metodo della consapevolezza consiste nel riuscire a stare negli spazi tra i Sè dissociati.
Nel frattempo le mie meditazioni sono diventate più regolari, ormai riesco a meditare quasi tutti i giorni, ho cominciato con quindici minuti al giorno, ora sto cercando di meditare per mezzora, perché mi accorgo che solo dopo un certo tempo, se supero il flusso continuo dei pensieri e li lascio scorrere, riesco a concentrarmi solo sul respiro e su una sorta di suono interiore.
E' diventato molto più facile immergersi nel flusso di consapevolezza, al punto che anche durante il giorno, se qualcosa mi irrita, mi rende inquieta, mi basta ricordarmi del mio respiro, ritornarvi per un attimo, per interrompere l'inquietudine, per distanziarmene. Non dico che quindi mi è sempre possibile superare le emozioni negative, però almeno è più facile identificare quali sono le emozioni, gli stati, le sensazioni, i sentimenti che sto provando. Poi posso anche rimanere, anzi in certi momenti non c'è altra soluzione che rimanere, con quella emozione, però con consapevolezza e chiarezza mentale. Come recita una massima buddista "per uscirne bisogna passarci in mezzo".
Anche la psicoterapia in fondo insegna qualcosa di molto simile: non è possibile evitare la nostra sofferenza, distogliere perennemente lo sguardo da ciò che ci ferisce, cercare in ogni modo, più o meno nevrotico, di evitare i pensieri, i ricordi, i nostri stati traumatizzati. Per trovare una soluzione è necessario passarci in mezzo, accettare di analizzare, ricordare, stare con quelle emozioni, stare in mezzo al conflitto, alla mancanza, alla ambiguità.
Anche la psicoterapia, quando è condotta senza eccessivo coinvolgimento del terapeuta, cioè senza che il terapeuta abbia già pronte delle risposte, lascia al paziente uno stato di attenzione libera e fluttuante nella quale è lui stesso e solo lui a trovare una risposta ai suoi dilemmi. Quello che succede spesso però in alcune psicoterapie è che le parole più superficiali, le razionalizzazioni, occupano molto spazio, troppo rispetto al flusso di coscienza spontaneo del paziente.
La tecnica della meditazione Mindfulness permette di creare all'interno di se stessi uno spazio nel quale il flusso dei pensieri, delle emozioni e delle sensazioni può scorrere ed autosservarsi.
Perché nessuno può garantirci la felicità in questa vita, neanche la serenità, se non siamo disposti ad attraversarla in ogni momento di tristezza, gioia, disperazione o esaltazione con partecipazione consapevole e distaccata.
E' un principio semplice da dire, ma molto più complesso da mantenere: si dice "vivi ogni momento come fosse l'ultimo", perché è facile capire l'immensa fragilità della nostra esperienza.
Ma poi giorno per giorno ci attacchiamo ai nostri desideri, alle passioni, anche alla nostra frustrazione e sofferenza, come se fossero assolute.
Nelle mie meditazioni un pensiero che torna spesso è la perdita di Matilde, ovviamente. Molte volte questo pensiero si associa alle lacrime, che lascio scorrere. Ma più frequentemente Matilde dona una luce di relativismo a tutto il resto, diventa come un metro col quale misurare ogni preoccupazione, ogni angoscia, mi ricorda incessantemente che tutto quello per cui mi posso preoccupare giorno dopo giorno non è nulla di fronte al ciclo delle vite e delle morti nel quale siamo tutti inseriti. Mi fa sperimentare, nella ferita che si rinnova, la necessità di apprezzare tutto e allo stesso tempo di non attaccarmi a nulla di quello che vivo.
L'aspetto interessante della sua analisi è il tentativo di leggere la figura del Buddha ed il suo messaggio come il frutto della elaborazione del trauma della perdita della madre.
Tale elaborazione si compie attraverso gli anni nei quali il principe Siddharta ricerca una soluzione alla consapevolezza del dolore della esistenza, prova varie pratiche e filosofie ascetiche, ma alla fine sotto l'albero della Bodhi raggiunge l'illuminazione. Il ricordo di un momento di gioia della sua infanzia, un momento nel quale Siddharta sembra recuperare uno stato di unione con la madre perduta, dissociato dal momento del suo trauma, sembra essere la radice che permette di osservare e tollerare la sofferenza del mondo.
Il trauma provoca una dissociazione delle emozioni catastrofiche dallo stato di coscienza attuale. A volte anche alcuni stati primitivi di de-sincronizzazione nella relazione tra la madre ed il neonato, secondo alcune odierne scuole psicoanalitiche, possono provocare stati emotivi che vengono dissociati.
Seguendo uno studioso, lo psicoanalista Philip Bromberg, autore di Clinica del trauma e della dissociazione, si potrebbe dire che il modello che il Buddha propone come metodo della consapevolezza consiste nel riuscire a stare negli spazi tra i Sè dissociati.
Nel frattempo le mie meditazioni sono diventate più regolari, ormai riesco a meditare quasi tutti i giorni, ho cominciato con quindici minuti al giorno, ora sto cercando di meditare per mezzora, perché mi accorgo che solo dopo un certo tempo, se supero il flusso continuo dei pensieri e li lascio scorrere, riesco a concentrarmi solo sul respiro e su una sorta di suono interiore.
E' diventato molto più facile immergersi nel flusso di consapevolezza, al punto che anche durante il giorno, se qualcosa mi irrita, mi rende inquieta, mi basta ricordarmi del mio respiro, ritornarvi per un attimo, per interrompere l'inquietudine, per distanziarmene. Non dico che quindi mi è sempre possibile superare le emozioni negative, però almeno è più facile identificare quali sono le emozioni, gli stati, le sensazioni, i sentimenti che sto provando. Poi posso anche rimanere, anzi in certi momenti non c'è altra soluzione che rimanere, con quella emozione, però con consapevolezza e chiarezza mentale. Come recita una massima buddista "per uscirne bisogna passarci in mezzo".
Anche la psicoterapia in fondo insegna qualcosa di molto simile: non è possibile evitare la nostra sofferenza, distogliere perennemente lo sguardo da ciò che ci ferisce, cercare in ogni modo, più o meno nevrotico, di evitare i pensieri, i ricordi, i nostri stati traumatizzati. Per trovare una soluzione è necessario passarci in mezzo, accettare di analizzare, ricordare, stare con quelle emozioni, stare in mezzo al conflitto, alla mancanza, alla ambiguità.
Anche la psicoterapia, quando è condotta senza eccessivo coinvolgimento del terapeuta, cioè senza che il terapeuta abbia già pronte delle risposte, lascia al paziente uno stato di attenzione libera e fluttuante nella quale è lui stesso e solo lui a trovare una risposta ai suoi dilemmi. Quello che succede spesso però in alcune psicoterapie è che le parole più superficiali, le razionalizzazioni, occupano molto spazio, troppo rispetto al flusso di coscienza spontaneo del paziente.
La tecnica della meditazione Mindfulness permette di creare all'interno di se stessi uno spazio nel quale il flusso dei pensieri, delle emozioni e delle sensazioni può scorrere ed autosservarsi.
Perché nessuno può garantirci la felicità in questa vita, neanche la serenità, se non siamo disposti ad attraversarla in ogni momento di tristezza, gioia, disperazione o esaltazione con partecipazione consapevole e distaccata.
E' un principio semplice da dire, ma molto più complesso da mantenere: si dice "vivi ogni momento come fosse l'ultimo", perché è facile capire l'immensa fragilità della nostra esperienza.
Ma poi giorno per giorno ci attacchiamo ai nostri desideri, alle passioni, anche alla nostra frustrazione e sofferenza, come se fossero assolute.
Nelle mie meditazioni un pensiero che torna spesso è la perdita di Matilde, ovviamente. Molte volte questo pensiero si associa alle lacrime, che lascio scorrere. Ma più frequentemente Matilde dona una luce di relativismo a tutto il resto, diventa come un metro col quale misurare ogni preoccupazione, ogni angoscia, mi ricorda incessantemente che tutto quello per cui mi posso preoccupare giorno dopo giorno non è nulla di fronte al ciclo delle vite e delle morti nel quale siamo tutti inseriti. Mi fa sperimentare, nella ferita che si rinnova, la necessità di apprezzare tutto e allo stesso tempo di non attaccarmi a nulla di quello che vivo.
giovedì 26 febbraio 2015
La sottomissione, l'Islam, Marte e Venere.
Una riflessione che ho fatto leggendo il libro Sottomissione riguarda il ruolo delle donne. Mi sembrava incredibile che in quella storia le donne occidentali accettassero la sottomissione agli uomini, un cambiamento così radicale del loro ruolo. Mi sono così identificata in tale ipotesi che ho immaginato forme di protesta e contestazione, così come avrebbe dovuto descriverle nel romanzo Houellebecq, se fosse un autore meno misogino di quello che ci tiene ad apparire.
Ho cominciato poi a ragionare sul perché nei paesi arabi non ci siano movimenti di protesta delle donne, almeno dalle notizie che se ne hanno da noi. Mi sono allora informata un po' in internet ed ho trovato che nei paesi occidentali ci sono donne musulmane che spingono per adeguare la religione ai tempi moderni, sostenendo che non vi è un motivo religioso per escludere, ad esempio, le donne dalle moschee, o intendere la sottomissione al marito in senso letterale o seguire altre regole che sono consolidate secondo la tradizione, ma non hanno un senso morale.
Un punto base da comprendere della religione islamica è proprio che non c'è una unica guida o una unica comunità alla quale riferirsi, come è accaduto invece per la religione cristiana, che riconosce nel Papa e nel Concilio gli interpreti unici del messaggio cristiano. E' più difficile quindi per chi osserva dall'esterno orientarsi negli usi e nelle forme che prende la religione musulmana a seconda della comunità (sunnita, scita, salafita ecc.)
Quindi quando anche alcune comunità cominciassero a modificare le proprie tradizioni religiose e culturali, queste non sarebbero automaticamente accettate da altre comunità, più profondamente inserite in contesti nei quali ad esempio il ruolo della donna è ancora quello della famiglia patriarcale. Le battaglie del femminismo_islamico si svolgono in prevalenza nei paesi occidentali.
Del resto anche nelle democrazie europee o nordamericane il ruolo della donna si è modificato prima nell'ambito socioeconomico e poi nella cultura e quindi nella religione. Sono state le rivoluzioni, da quella francese a quella industriale a modificare la funzione sociale delle donne. C'è stata una lunga e tormentata storia della nascita dei diritti femminili, che ancora non possono dirsi, neanche in occidente, del tutto acquisiti, soprattutto quelli sostanziali.
L'interpretazione più retrograda del ruolo delle donne all'interno dell'Islam è forte in paesi nei quali non c'è stata né rivoluzione industriale e né la necessità del lavoro diffuso delle donne.
Nelle nostre società è stata la seconda guerra mondiale a modificare i rapporti uomo donna nel mondo del lavoro, perché la necessità di sostituire gli uomini impegnati sui fronti di guerra ( un tipo di guerra certo diversa, meno tecnologica, di quelle che si combattono oggi) ha dato accesso alla indipendenza economica, prima base dell'indipendenza femminile.
La ricchezza della Arabia Saudita, monarchia assoluta nella quale vige come legge solo la Sharia, non è basata su una economia manifatturiera, ma sullo sfruttamento delle risorse. L'industria petrolifera impiega molta manodopera straniera, non sembra aver creato un ceto medio di servizi nei quali sia fondamentale anche il lavoro femminile. Così si crea un corto circuito nel quale meno le donne lavorano, meno sono istruite, meno combattono per i loro diritti.
Sembra allora che non sia pensabile una evoluzione politica dei diritti femminili e di tutti i diritti della persona in questi stati governati secondo le leggi islamiche non a causa della religione, ma a causa, come sosteneva un certo Karl Marx, delle strutture economiche e quindi sociali.
Però non sembra così semplice capire la diversità tra i paesi musulmani e i paesi occidentali. E' facile fare confusione tra il piano politico/economico e quello religioso/culturale-
Le notizie di questi giorni (la guerra dell'ISIS in Siria e in Libia, gli attacchi terroristici in Danimarca) portano di nuovo in auge commenti ostili all'Islam e ai musulmani.
Molti infatti reagiscono all'orrore delle immagini delle decapitazioni attaccando la religione dell'Islam, altri cercano di tenere conto delle sfumature tra i moderati e i "fondamentalisti", ma rischiano forse in questo modo di non prendere una posizione più netta nei confronti di alcune comunità musulmane che non rispettano i diritti individuali e che quindi possono avvallare alcune motivazioni propagandistiche dei terroristi e dell'ISIS.
Alcuni studiosi, tra i quali Franco Cardini, sostengono invece che le differenze tra Islam e Cristianità non sono poi così rilevanti e che in realtà la crisi attuale tra occidente e musulmani nasce dai vari tradimenti che il mondo delle democrazie occidentali ha perpetuato verso il mondo islamico: la questione palestinese, la spartizione dell'area araba tra le potenze coloniali, l'abbandono dell'Africa alle multinazionali, senza supportare i processi democratici.
Mi sono posta molti dubbi, perché rientro sicuramente tra coloro che cercano di non avere un pregiudizio contro la religione musulmana ed in genere contro le religioni.
Ma cercando di capire mi sono chiesta come mai le religioni stiano diventando di nuovo ideologie politiche così militanti, così onnicomprensive e come sia possibile che molti giovani occidentali, anche donne, o giovani di paesi che comunque sono vissuti in modo laico, si facciano coinvolgere, si lascino conquistare dal fascino del fondamentalismo.
C'è una contraddizione nel nostro modo di pensare tra un principio di relativismo culturale, che cerca di accettare sullo stesso piano tutti i valori delle diverse culture e/o religioni, e un principio che difende comunque alcuni valori, come quelli della persona, come centrali, migliori, assoluti.
L'Islam appare come una religione che non accetta i diritti individuali, nella sua ideologia è centrale la comunità, è alla comunità religiosa che si sottomettono i credenti, solo nella partecipazione alle leggi della comunità si è riconosciuti.
La Dichiarazione_islamica_dei_diritti_dell'uomo sottomette i diritti individuali alla legge islamica del Corano e della Sunna. La dichiarazione non prevede ad esempio la parità di diritti tra uomo e donna. E' stata elaborata proprio perché per alcune nazioni era impossibile aderire, per le differenze culturali basate sulla adesione alle leggi islamiche, alla Dichiarazione_universale_dei_diritti_umani dell'Onu.
Ad un interessante incontro della Associazione Metis e della Associazione Plinio Tammaro, "Mutamenti dell'anima e scenari del mondo", si discuteva della interpretazione dei recenti eventi politici e delle guerre nel medio-oriente alla luce delle teorie di James Hillman, psicoanalista junghiano che spesso si è occupato di leggere i fenomeni sociali attraverso gli archetipi. Durante il vivace dibattito tra i relatori (Eliana Belli, Maria Paola Moretti e David Tammaro) ed il pubblico sulle immagini della guerra, sull'intreccio tra gli aspetti sociali e i miti culturali e religiosi, sulla diversa appartenenza alla comunità nelle società musulmane od occidentali, sulla contrapposizione tra "noi" e "loro", su quanto si può rispondere all'odio della guerra di Marte con l'amore di Venere ho cominciato a pensare che potrebbero essere le donne a modificare l'Islam. Sarebbe bello e significativo, come è successo in alcune primavere arabe, che fossero loro a combattere perché venga riconosciuta la loro capacità e indipendenza, i loro diritti e così anche a modificare le comunità ed i paesi musulmani. Solo nella integrazione degli opposti, nella democrazia e nel confronto del dialogo si può trovare una via pacifica alla convivenza.
Ho cominciato poi a ragionare sul perché nei paesi arabi non ci siano movimenti di protesta delle donne, almeno dalle notizie che se ne hanno da noi. Mi sono allora informata un po' in internet ed ho trovato che nei paesi occidentali ci sono donne musulmane che spingono per adeguare la religione ai tempi moderni, sostenendo che non vi è un motivo religioso per escludere, ad esempio, le donne dalle moschee, o intendere la sottomissione al marito in senso letterale o seguire altre regole che sono consolidate secondo la tradizione, ma non hanno un senso morale.
Un punto base da comprendere della religione islamica è proprio che non c'è una unica guida o una unica comunità alla quale riferirsi, come è accaduto invece per la religione cristiana, che riconosce nel Papa e nel Concilio gli interpreti unici del messaggio cristiano. E' più difficile quindi per chi osserva dall'esterno orientarsi negli usi e nelle forme che prende la religione musulmana a seconda della comunità (sunnita, scita, salafita ecc.)
Quindi quando anche alcune comunità cominciassero a modificare le proprie tradizioni religiose e culturali, queste non sarebbero automaticamente accettate da altre comunità, più profondamente inserite in contesti nei quali ad esempio il ruolo della donna è ancora quello della famiglia patriarcale. Le battaglie del femminismo_islamico si svolgono in prevalenza nei paesi occidentali.
Del resto anche nelle democrazie europee o nordamericane il ruolo della donna si è modificato prima nell'ambito socioeconomico e poi nella cultura e quindi nella religione. Sono state le rivoluzioni, da quella francese a quella industriale a modificare la funzione sociale delle donne. C'è stata una lunga e tormentata storia della nascita dei diritti femminili, che ancora non possono dirsi, neanche in occidente, del tutto acquisiti, soprattutto quelli sostanziali.
L'interpretazione più retrograda del ruolo delle donne all'interno dell'Islam è forte in paesi nei quali non c'è stata né rivoluzione industriale e né la necessità del lavoro diffuso delle donne.
Nelle nostre società è stata la seconda guerra mondiale a modificare i rapporti uomo donna nel mondo del lavoro, perché la necessità di sostituire gli uomini impegnati sui fronti di guerra ( un tipo di guerra certo diversa, meno tecnologica, di quelle che si combattono oggi) ha dato accesso alla indipendenza economica, prima base dell'indipendenza femminile.
La ricchezza della Arabia Saudita, monarchia assoluta nella quale vige come legge solo la Sharia, non è basata su una economia manifatturiera, ma sullo sfruttamento delle risorse. L'industria petrolifera impiega molta manodopera straniera, non sembra aver creato un ceto medio di servizi nei quali sia fondamentale anche il lavoro femminile. Così si crea un corto circuito nel quale meno le donne lavorano, meno sono istruite, meno combattono per i loro diritti.
Sembra allora che non sia pensabile una evoluzione politica dei diritti femminili e di tutti i diritti della persona in questi stati governati secondo le leggi islamiche non a causa della religione, ma a causa, come sosteneva un certo Karl Marx, delle strutture economiche e quindi sociali.
Però non sembra così semplice capire la diversità tra i paesi musulmani e i paesi occidentali. E' facile fare confusione tra il piano politico/economico e quello religioso/culturale-
Le notizie di questi giorni (la guerra dell'ISIS in Siria e in Libia, gli attacchi terroristici in Danimarca) portano di nuovo in auge commenti ostili all'Islam e ai musulmani.
Molti infatti reagiscono all'orrore delle immagini delle decapitazioni attaccando la religione dell'Islam, altri cercano di tenere conto delle sfumature tra i moderati e i "fondamentalisti", ma rischiano forse in questo modo di non prendere una posizione più netta nei confronti di alcune comunità musulmane che non rispettano i diritti individuali e che quindi possono avvallare alcune motivazioni propagandistiche dei terroristi e dell'ISIS.
Alcuni studiosi, tra i quali Franco Cardini, sostengono invece che le differenze tra Islam e Cristianità non sono poi così rilevanti e che in realtà la crisi attuale tra occidente e musulmani nasce dai vari tradimenti che il mondo delle democrazie occidentali ha perpetuato verso il mondo islamico: la questione palestinese, la spartizione dell'area araba tra le potenze coloniali, l'abbandono dell'Africa alle multinazionali, senza supportare i processi democratici.
Mi sono posta molti dubbi, perché rientro sicuramente tra coloro che cercano di non avere un pregiudizio contro la religione musulmana ed in genere contro le religioni.
Ma cercando di capire mi sono chiesta come mai le religioni stiano diventando di nuovo ideologie politiche così militanti, così onnicomprensive e come sia possibile che molti giovani occidentali, anche donne, o giovani di paesi che comunque sono vissuti in modo laico, si facciano coinvolgere, si lascino conquistare dal fascino del fondamentalismo.
C'è una contraddizione nel nostro modo di pensare tra un principio di relativismo culturale, che cerca di accettare sullo stesso piano tutti i valori delle diverse culture e/o religioni, e un principio che difende comunque alcuni valori, come quelli della persona, come centrali, migliori, assoluti.
L'Islam appare come una religione che non accetta i diritti individuali, nella sua ideologia è centrale la comunità, è alla comunità religiosa che si sottomettono i credenti, solo nella partecipazione alle leggi della comunità si è riconosciuti.
La Dichiarazione_islamica_dei_diritti_dell'uomo sottomette i diritti individuali alla legge islamica del Corano e della Sunna. La dichiarazione non prevede ad esempio la parità di diritti tra uomo e donna. E' stata elaborata proprio perché per alcune nazioni era impossibile aderire, per le differenze culturali basate sulla adesione alle leggi islamiche, alla Dichiarazione_universale_dei_diritti_umani dell'Onu.
Ad un interessante incontro della Associazione Metis e della Associazione Plinio Tammaro, "Mutamenti dell'anima e scenari del mondo", si discuteva della interpretazione dei recenti eventi politici e delle guerre nel medio-oriente alla luce delle teorie di James Hillman, psicoanalista junghiano che spesso si è occupato di leggere i fenomeni sociali attraverso gli archetipi. Durante il vivace dibattito tra i relatori (Eliana Belli, Maria Paola Moretti e David Tammaro) ed il pubblico sulle immagini della guerra, sull'intreccio tra gli aspetti sociali e i miti culturali e religiosi, sulla diversa appartenenza alla comunità nelle società musulmane od occidentali, sulla contrapposizione tra "noi" e "loro", su quanto si può rispondere all'odio della guerra di Marte con l'amore di Venere ho cominciato a pensare che potrebbero essere le donne a modificare l'Islam. Sarebbe bello e significativo, come è successo in alcune primavere arabe, che fossero loro a combattere perché venga riconosciuta la loro capacità e indipendenza, i loro diritti e così anche a modificare le comunità ed i paesi musulmani. Solo nella integrazione degli opposti, nella democrazia e nel confronto del dialogo si può trovare una via pacifica alla convivenza.
sabato 17 gennaio 2015
Cuori affamati
Ero curiosa di vedere il film di Costanzo, dopo aver letto che trattava di una madre che non riusciva ad alimentare il figlio. Mi occupo spesso di Disturbi della alimentazione, anche nella prima infanzia. Non è un tema semplice da affrontare, quindi ero un po' scettica.
Il film è pieno di atmosfere angoscianti, anche se inizia con una scena davvero divertente.
Eppure quel modo così "corporeo" di avvicinarsi dei due protagonisti, in un bagno pubblico, alle prese con una crisi intestinale di Jude, dà la cifra anche al resto della loro storia, che è soprattutto una storia di corpi: quello della madre, che anche in gravidanza non prende abbastanza peso, quello del figlio, che non riesce a crescere, quello del padre, alto e magro, reso ancora più magro e allungato da riprese e da una fotografia che allungano e distorcono i corpi. Anche i colori e gli ambienti del piccolo appartamento, dal quale madre e figlio non escono per diversi mesi, sono distorti, innaturali.
Il rapporto tra naturale e artificiale è anche un'altra prospettiva della storia: Mina sostiene che gli alimenti che il pediatra vorrebbe dare al bambino sono veleno, e allo stesso tempo nutre il bambino in modo del tutto innaturale, con semi e olii depurativi. Jude prova ad assecondarla, ma poi si accorge che suo figlio non sta bene, non cresce come dovrebbe e lo porta fuori per alimentarlo di nascosto.
Il regista da Fazio ed in altre interviste dice che sono personaggi che amano troppo.
Non sono d'accordo, non si tratta di amore eccessivo, si tratta di un vuoto d'amore.
Non dico che Mina non ami suo figlio, ma che il suo amore non riesce a riempirlo, perché lei stessa è vuota, ferita, angosciata di perderlo, ossessionata di purificarlo da una possibile minaccia.
Sempre più spesso incontro ragazze che nascondono il loro problema con il cibo, ma in realtà la croce di non riuscire ad amarsi, dietro la rivendicazione di una alimentazione sana. Allora dicono di non mangiare cereali come il grano perché fanno male, evitano del tutto la carne o i latticini perché vegane, si nutrono solo di semi e verdure. portano avanti ossessioni alimentari squilibrate ed incoerenti.
Cercano una purezza, una "verità", una "anima" da introdurre attraverso il cibo, o un "demone" da evitare per superare le paure, per sentirsi a posto.
Senza riuscirci. Come non ci riesce Mina.
Jude prova a fare quello che succede a molti familiari di persone ossessionate: assecondano, discutono, alla fine si ribellano e sono costretti a mettere in atto comportamenti scorretti.
Il film è bello perché non giudica, non riduce i protagonisti a "malati", racconta solo la loro storia e lo fa con atmosfere e immagini, più che con le parole.
Solo sul finale avrei qualche dubbio, però forse non poteva che finire così.
Il film è pieno di atmosfere angoscianti, anche se inizia con una scena davvero divertente.
Eppure quel modo così "corporeo" di avvicinarsi dei due protagonisti, in un bagno pubblico, alle prese con una crisi intestinale di Jude, dà la cifra anche al resto della loro storia, che è soprattutto una storia di corpi: quello della madre, che anche in gravidanza non prende abbastanza peso, quello del figlio, che non riesce a crescere, quello del padre, alto e magro, reso ancora più magro e allungato da riprese e da una fotografia che allungano e distorcono i corpi. Anche i colori e gli ambienti del piccolo appartamento, dal quale madre e figlio non escono per diversi mesi, sono distorti, innaturali.
Il rapporto tra naturale e artificiale è anche un'altra prospettiva della storia: Mina sostiene che gli alimenti che il pediatra vorrebbe dare al bambino sono veleno, e allo stesso tempo nutre il bambino in modo del tutto innaturale, con semi e olii depurativi. Jude prova ad assecondarla, ma poi si accorge che suo figlio non sta bene, non cresce come dovrebbe e lo porta fuori per alimentarlo di nascosto.
Il regista da Fazio ed in altre interviste dice che sono personaggi che amano troppo.
Non sono d'accordo, non si tratta di amore eccessivo, si tratta di un vuoto d'amore.
Non dico che Mina non ami suo figlio, ma che il suo amore non riesce a riempirlo, perché lei stessa è vuota, ferita, angosciata di perderlo, ossessionata di purificarlo da una possibile minaccia.
Sempre più spesso incontro ragazze che nascondono il loro problema con il cibo, ma in realtà la croce di non riuscire ad amarsi, dietro la rivendicazione di una alimentazione sana. Allora dicono di non mangiare cereali come il grano perché fanno male, evitano del tutto la carne o i latticini perché vegane, si nutrono solo di semi e verdure. portano avanti ossessioni alimentari squilibrate ed incoerenti.
Cercano una purezza, una "verità", una "anima" da introdurre attraverso il cibo, o un "demone" da evitare per superare le paure, per sentirsi a posto.
Senza riuscirci. Come non ci riesce Mina.
Jude prova a fare quello che succede a molti familiari di persone ossessionate: assecondano, discutono, alla fine si ribellano e sono costretti a mettere in atto comportamenti scorretti.
Il film è bello perché non giudica, non riduce i protagonisti a "malati", racconta solo la loro storia e lo fa con atmosfere e immagini, più che con le parole.
Solo sul finale avrei qualche dubbio, però forse non poteva che finire così.
mercoledì 8 ottobre 2014
Il docufilm e la psicoterapia.
Questa estate ho scoperto un particolare genere di film, il film-documentario.
Avevo mancato al cinema Sacro GRA, ma l'ho rivisto su SKY, mentre alla Cava di Roselle ho assistito a Ritratti abusivi . Durante la manifestazione estiva Muramonamour abbiamo scoperto Le cose belle, di cui ho già parlato.
E' un genere documentario narrativo, quello in cui si riprende la vita vera, con personaggi veri, ma con una storia che può essere scritta o montata a costruire una narrazione.
Si tratta di un film perchè narra con le immagini, di un documentario perchè in genere i personaggi interpretano loro stessi, ed anche perchè i luoghi, gli eventi sono reali.
Però sono guardati da un punto di vista unitario che inevitabilmente immette nello sguardo la sua interpretazione.
Il regista sembra diventare uno svelatore di senso delle esistenze dei suoi personaggi.
In Sacro GRA le storie che si intravedono acquistano profondità attraverso le inquadrature ed il montaggio, acquistano un senso metaforico che non potevano avere prima che il regista le ricostruisse nel suo orizzonte narrativo.
E' una operazione che ha molto in comune con il lavoro maiueutico della psicoterapia.
Si tratta di donare connessioni di significato nuove a vite stanche e usurate: la bellezza cadente delle antiche prostitute, la fotografia magnifica del traffico sul Grande raccordo, la solitudine del lavoro d'aiuto sulle ambulanze, la caparbietà dello scovare le larve.
Anche in Ritratti Abusivi le esistenze che si aggirano nei luoghi semi abbandonati del Parco Saraceno, negletti e curati allo stesso tempo, delle residenze costruite dai militari americani e poi lasciate in eredità (si fa per dire) a persone che non hanno alternative abitative, appaiono definite e decifrate dal montaggio del regista. I ritratti emergono dalle interviste, ma come sa bene ogni giornalista, ed ogni psicoterapeuta, le domande giuste "tirano fuori" la storia.
Come se non bastasse la vita vera, come se la vita diventasse vera solo se riletta e ricostruita.
Mi è apparsa come l'essenza del lavoro psicoterapeutico.
Spesso le persone pensano che gli psicoterapeuti siano degli investigatori, siano quelli che cercano la verità.
Pensano che abbiano degli strumenti particolari che rivelino un sostrato di conoscenze, che portino a galla una conoscenza seppellita, ferma e pronta ad essere svelata, come un tesoro che va solo fatto affiorare.
Mentre potremmo pensare che gli psicoterapeuti aiutino le persone a diventare i registi della propria vita, a donare un senso nuovo agli eventi che hanno vissuto e che spesso rtornano perchè ancora caotici, non elaborati o rigidamente incasellati in convinzioni distorte.
Allora la psicoterapia non è un film giallo, non trova il colpevole, la psicoterapia è un docu-film che ri-narra la vita vera.
Avevo mancato al cinema Sacro GRA, ma l'ho rivisto su SKY, mentre alla Cava di Roselle ho assistito a Ritratti abusivi . Durante la manifestazione estiva Muramonamour abbiamo scoperto Le cose belle, di cui ho già parlato.
E' un genere documentario narrativo, quello in cui si riprende la vita vera, con personaggi veri, ma con una storia che può essere scritta o montata a costruire una narrazione.
Si tratta di un film perchè narra con le immagini, di un documentario perchè in genere i personaggi interpretano loro stessi, ed anche perchè i luoghi, gli eventi sono reali.
Però sono guardati da un punto di vista unitario che inevitabilmente immette nello sguardo la sua interpretazione.
Il regista sembra diventare uno svelatore di senso delle esistenze dei suoi personaggi.
In Sacro GRA le storie che si intravedono acquistano profondità attraverso le inquadrature ed il montaggio, acquistano un senso metaforico che non potevano avere prima che il regista le ricostruisse nel suo orizzonte narrativo.
E' una operazione che ha molto in comune con il lavoro maiueutico della psicoterapia.
Si tratta di donare connessioni di significato nuove a vite stanche e usurate: la bellezza cadente delle antiche prostitute, la fotografia magnifica del traffico sul Grande raccordo, la solitudine del lavoro d'aiuto sulle ambulanze, la caparbietà dello scovare le larve.
Anche in Ritratti Abusivi le esistenze che si aggirano nei luoghi semi abbandonati del Parco Saraceno, negletti e curati allo stesso tempo, delle residenze costruite dai militari americani e poi lasciate in eredità (si fa per dire) a persone che non hanno alternative abitative, appaiono definite e decifrate dal montaggio del regista. I ritratti emergono dalle interviste, ma come sa bene ogni giornalista, ed ogni psicoterapeuta, le domande giuste "tirano fuori" la storia.
Come se non bastasse la vita vera, come se la vita diventasse vera solo se riletta e ricostruita.
Mi è apparsa come l'essenza del lavoro psicoterapeutico.
Spesso le persone pensano che gli psicoterapeuti siano degli investigatori, siano quelli che cercano la verità.
Pensano che abbiano degli strumenti particolari che rivelino un sostrato di conoscenze, che portino a galla una conoscenza seppellita, ferma e pronta ad essere svelata, come un tesoro che va solo fatto affiorare.
Mentre potremmo pensare che gli psicoterapeuti aiutino le persone a diventare i registi della propria vita, a donare un senso nuovo agli eventi che hanno vissuto e che spesso rtornano perchè ancora caotici, non elaborati o rigidamente incasellati in convinzioni distorte.
Allora la psicoterapia non è un film giallo, non trova il colpevole, la psicoterapia è un docu-film che ri-narra la vita vera.
giovedì 12 aprile 2012
La psicologa della mutua
Ho scelto un lavoro complicato. E' bellissimo e entusiasmante a volte, per quanto è stressante e frustrante altre. Sugli psicologi si dicono tante cose: si dice che fanno questo lavoro perchè sono loro stessi un po' pazzi ed hanno scelto di curare gli altri per curare se stessi. Si dice che cercano la gratificazione che prova chi dà aiuto. Si dice che possano sentirsi onnipotenti e possano ammalarsi di narcisismo. Si dice anche che rischiano di manipolare le persone che si rivolgono a loro. Insomma non se ne parla poi troppo bene, però alcuni di questi pensieri contengono una parte di verità.
Per me la parte entusiasmante risiede nel sentire di essere stata d'aiuto. Ho già scritto di questo, di come a volte riesco a sentire di aver riparato ad una ingiustizia. E' innegabile che quando finisco una psicoterapia o una consulenza ai genitori con la consapevolezza che qualcosa è cambiato, qualcosa nella vita di quelle persone è migliorato, anche grazie al mio intervento, mi sento gratificata. Mi sento bene anche quando non mi viene riconosciuto direttamente, non c'è bisogno che mi venga detto. So anche bene che i miei sforzi sono solo una parte del risultato e che il lavoro più grande lo fanno le persone, i bambini, gli adolescenti, i genitori, gli insegnanti. Se non c'è una sinergia tra gli sforzi di tutti non è possibile arrivare ad un cambiamento.
Infatti a volte il cambiamento non avviene.
A volte sembra che tutti gli sforzi che si fanno non portino ad una vera svolta, oppure che il cambiamento avvenga così lentamente che appare irrilevante. A volte le persone lasciano, abbandonano, oppure persistono negli schemi di comportamento disadattivi.
A volte non c'è la consapevolezza che è necessario cambiare. A volte la situazione sintomatica costituisce l'unica modalità che le famiglie conoscono o accettano per affrontare la vita.
In questi casi mi sento impotente, inutile, incapace. Nonostante sappia che non è possibile innescare ogni volta tutte le variabili che producono un cambiamento, continuo a chiedermi se non c'è qualcosa che ho trascurato, qualcosa che avrei potuto capire meglio o prendere in considerazione in modo diverso.
Provo allora a parlare con i colleghi, a cercare altri tipi di approcci. Sono una psicologa eclettica, non mi sono formata in una scuola di psicoterapia "ortodossa" e non seguo un solo metodo. Certo preferisco nella psicoterapia individuale dei bambini e degli adolescenti l'approccio psicodinamico, ma a volte non disdegno di usare tecniche di stampo cognitivista. Con i genitori spesso mi ritrovo ad utilizzare tecniche comportamentali, che trovo molto utili quando i bambini mostrano sintomi oppositivi, aggressivi, disregolati. Sempre trovo utile avere un'ottica sistemico-relazionale nel comprendere le relazioni familiari ed a volte utilizzo la psicoterapia familiare come intervento principale, anche se sono limitata dal fatto che è necessario che ci sia un coterapeuta.
Spesso infatti i limiti dell'intervento sono oggettivamente quelli del lavoro nella struttura pubblica: i casi sono molti ed il personale è sempre più ridotto. I servizi non sono organizzati nel modo migliore, a volte la burocrazia allunga i tempi o rende difficile la formazione specifica, il reperimento del materiale pià aggiornato. Ad esempio abbiamo una stanza per la psicoterapia familiare, che prevede l'uso dello specchio unidirezionale, ma l'impianto di videoregistrazione non funziona correttamente e comprarne uno nuovo è troppo costoso per il budget di questo anno. Inoltre nel mio servizio non ci sono colleghi formati alla terapia familiare ed il progetto di creare un gruppo specializzato a cavallo di più servizi non è ancora decollato.
I progetti non mancano, ne abbiamo diversi molto buoni, ma trovare i finanziamenti è sempre un'impresa. Poi, quando riusciamo ad avere la delibera, ci vogliono mesi per avere i soldi disponibili. Per non parlare del fatto che a volte mi ritrovo a svolgere compiti che non mi spettano. Stamani ho svolto tre colloqui e due psicoterapie e negli intervelli tra un colloquio e l'altro sono andata a supervisionare un trasloco nei nuovi locali per il Centro Diurno per l'Autismo. Durante le vacanze di Natale io ed il mio capo ci siamo ritrovati per imbiancare i locali dove il centro era stato temporaneamente assegnato!!! Certamente avremmo potuto chiedere che lo facessero gli operai, ma avremmo dovuto aspettare altro tempo ed intanto le famiglie non potevano più attendere.
Insomma noi operatori della salute mentale nei servizi è come se fossimo ancora in trincea. Mi dicono che nelle regioni più ricche del Nord le cose vanno meglio, ci sono più risorse e maggiore specializzazione, chissà forse lì non mi sentirei una psicologa della mutua.
Quando penso a tutto questo, alla fatica e alle frustrazioni, ma anche ai piccoli grandi successi, al sorriso con il quale una mamma mi saluta nel corridoio rivedendomi dopo alcuni anni, mi sembra di fare un gran bel lavoro. Devo ricordarmelo più spesso, ecco. Oggi è stata una di quelle giornate faticose e un po' tristi ed avevo bisogno di ripercorre i motivi per cui domani mi alzerò, mi preparerò ed andrò a timbrare il mio ingresso alla ASL.
Buonanotte.
(eh si, questa è proprio una forma di autoterapia!!!)
Per me la parte entusiasmante risiede nel sentire di essere stata d'aiuto. Ho già scritto di questo, di come a volte riesco a sentire di aver riparato ad una ingiustizia. E' innegabile che quando finisco una psicoterapia o una consulenza ai genitori con la consapevolezza che qualcosa è cambiato, qualcosa nella vita di quelle persone è migliorato, anche grazie al mio intervento, mi sento gratificata. Mi sento bene anche quando non mi viene riconosciuto direttamente, non c'è bisogno che mi venga detto. So anche bene che i miei sforzi sono solo una parte del risultato e che il lavoro più grande lo fanno le persone, i bambini, gli adolescenti, i genitori, gli insegnanti. Se non c'è una sinergia tra gli sforzi di tutti non è possibile arrivare ad un cambiamento.
Infatti a volte il cambiamento non avviene.
A volte sembra che tutti gli sforzi che si fanno non portino ad una vera svolta, oppure che il cambiamento avvenga così lentamente che appare irrilevante. A volte le persone lasciano, abbandonano, oppure persistono negli schemi di comportamento disadattivi.
A volte non c'è la consapevolezza che è necessario cambiare. A volte la situazione sintomatica costituisce l'unica modalità che le famiglie conoscono o accettano per affrontare la vita.
In questi casi mi sento impotente, inutile, incapace. Nonostante sappia che non è possibile innescare ogni volta tutte le variabili che producono un cambiamento, continuo a chiedermi se non c'è qualcosa che ho trascurato, qualcosa che avrei potuto capire meglio o prendere in considerazione in modo diverso.
Provo allora a parlare con i colleghi, a cercare altri tipi di approcci. Sono una psicologa eclettica, non mi sono formata in una scuola di psicoterapia "ortodossa" e non seguo un solo metodo. Certo preferisco nella psicoterapia individuale dei bambini e degli adolescenti l'approccio psicodinamico, ma a volte non disdegno di usare tecniche di stampo cognitivista. Con i genitori spesso mi ritrovo ad utilizzare tecniche comportamentali, che trovo molto utili quando i bambini mostrano sintomi oppositivi, aggressivi, disregolati. Sempre trovo utile avere un'ottica sistemico-relazionale nel comprendere le relazioni familiari ed a volte utilizzo la psicoterapia familiare come intervento principale, anche se sono limitata dal fatto che è necessario che ci sia un coterapeuta.
Spesso infatti i limiti dell'intervento sono oggettivamente quelli del lavoro nella struttura pubblica: i casi sono molti ed il personale è sempre più ridotto. I servizi non sono organizzati nel modo migliore, a volte la burocrazia allunga i tempi o rende difficile la formazione specifica, il reperimento del materiale pià aggiornato. Ad esempio abbiamo una stanza per la psicoterapia familiare, che prevede l'uso dello specchio unidirezionale, ma l'impianto di videoregistrazione non funziona correttamente e comprarne uno nuovo è troppo costoso per il budget di questo anno. Inoltre nel mio servizio non ci sono colleghi formati alla terapia familiare ed il progetto di creare un gruppo specializzato a cavallo di più servizi non è ancora decollato.
I progetti non mancano, ne abbiamo diversi molto buoni, ma trovare i finanziamenti è sempre un'impresa. Poi, quando riusciamo ad avere la delibera, ci vogliono mesi per avere i soldi disponibili. Per non parlare del fatto che a volte mi ritrovo a svolgere compiti che non mi spettano. Stamani ho svolto tre colloqui e due psicoterapie e negli intervelli tra un colloquio e l'altro sono andata a supervisionare un trasloco nei nuovi locali per il Centro Diurno per l'Autismo. Durante le vacanze di Natale io ed il mio capo ci siamo ritrovati per imbiancare i locali dove il centro era stato temporaneamente assegnato!!! Certamente avremmo potuto chiedere che lo facessero gli operai, ma avremmo dovuto aspettare altro tempo ed intanto le famiglie non potevano più attendere.
Insomma noi operatori della salute mentale nei servizi è come se fossimo ancora in trincea. Mi dicono che nelle regioni più ricche del Nord le cose vanno meglio, ci sono più risorse e maggiore specializzazione, chissà forse lì non mi sentirei una psicologa della mutua.
Quando penso a tutto questo, alla fatica e alle frustrazioni, ma anche ai piccoli grandi successi, al sorriso con il quale una mamma mi saluta nel corridoio rivedendomi dopo alcuni anni, mi sembra di fare un gran bel lavoro. Devo ricordarmelo più spesso, ecco. Oggi è stata una di quelle giornate faticose e un po' tristi ed avevo bisogno di ripercorre i motivi per cui domani mi alzerò, mi preparerò ed andrò a timbrare il mio ingresso alla ASL.
Buonanotte.
(eh si, questa è proprio una forma di autoterapia!!!)
martedì 14 febbraio 2012
Sempre a proposito di sessualità consapevole
Una insegnante di una quinta elementare mi ha chiamato per
chiedermi se potevo partecipare ad una riunione con i genitori dei suoi alunni.
Il problema era che nella sua classe si è parlato di sesso. Per meglio dire i
bambini hanno parlato di sesso tra di loro, in particolare di video a contenuto
sessuale che alcuni avrebbero visto e dei quali avrebbero raccontato agli
altri. Poi i grandi l'hanno saputo e ne hanno parlato alle maestre, che hanno
pensato ad una assemblea nella quale informare tutti i genitori.
Tra i bambini e i grandi non sono avvenute altre
comunicazioni oltre le indagini che singolarmente ogni famiglia ha fatto con i
propri figli, per sapere se sapevano, quanto sapevano e chi era stato il
"mandante", l'inizio di tutto.
Una volta appurato che nulla era avvenuto per contatti con
presunti pedofili (il fantasma che era stato evocato dal alcuni) le insegnanti
si sono chieste se non fosse il caso di parlare con i bambini di sesso, di
pornografia, dei giochi che a volte appaiono, cercando altro, su Google,
di YouTube, dei pericoli di cercare
informazioni su Internet. Cioè se non fosse il caso di fare un po' di sana
educazione sessuale.
Sana ma evidentemente ancora impossibile .
Infatti non c'è stato verso di discutere sul serio questa
possibilità.
I genitori si sono divisi in due gruppi, quelli che hanno appurato che i
propri figli non c'entravano nulla e che si sono sentiti sollevati (per
quanto?) e quelli che hanno invece dovuto fare le indagini ed affrontare anche
le domande dei figli sul tema. Ma una volta appurata questa divisione il
problema è stato accantonato. Come si diceva una volta "i panni sporchi si
lavano in famiglia". La proposta di farli lavare in comunità non è stata
affatto presa in considerazione.
Qualche tempo fa scrivevo della mancanza di una sessualità
consapevole negli adolescenti e nei giovani.
Ma come possono vivere consapevolmente il sesso se noi non
ci poniamo il problema di formarli a questo, come possono essere educati se i
mezzi di informazione che hanno a disposizione sono la pornografia, i racconti
degli amici, le mezze verità che passano nella scuola quando si parla del corpo
umano? Come si può pensare che ci sarà mai una cultura davvero aperta e non
discriminatoria se nessuno discute con i bambini degli orientamenti sessuali,
di cosa significa essere gay o transessuale, di quali sono le forme del sesso?
Penso da tempo che si dovrebbe fare educazione sessuale
alle scuole materne, alle scuole elementari e alle superiori, ogni volta nel
modo appropriato all'età, ma ogni volta parlandone. Invece addirittura
l'Educazione Sessuale che una volta veniva fatta dai Consultori delle ASL è
stata trasformata in Educazione all'Affettività, che è interessante, ma è,
permettetemi, un'altra cosa.
La sessualità non è un tema che possiamo lasciare solo
alle famiglie, perchè ci sono le famiglie in grado di affrontarlo e ci
sono le famiglie che preferiscono chiudere gli occhi e pensare che i bambini
sono angioletti innocenti finchè qualche sporco pedofilo li disturba.
Dimenticando e non volendo avere coscienza che se i bambini fossero informati
sul sesso sarebbero anche meno preda dei pedofili (che poi spesso sono
frequentatori della famiglia, quando non familiari stessi).
Lo so, sto affrontando temi difficili e delicati e so che
molti potrebbero non essere d'accordo. Ne ho avuto piena percezione in quella
assemblea nella quale non sono mancati i risolini imbarazzati, i richiami alla
malattia di chi guarda la pornografia, l'imbarazzo di affrontare il tema con i
figli, la vergogna di chi si è sentito coinvolto. Nonostante tutti
concordassero sul fatto che il sesso non è un tabù, a me invece è sembrato
che lo sia ancora.
I bambini hanno curiosità sul sesso, è sempre stato
normale e lo è ancora di più in una società nella quale le pubblicità, i mezzi
di intrattenimento, internet sono pieni di riferimenti sessuali. Però poi ci
stupiamo e ci facciamo un problema se i bambini ci chiedono o ancora peggio
vanno a cercare informazioni laddove c'è un grosso rischio che ne abbiano di
distorte. Non basta proibire, mettere filtri, controllare.
E' necessario parlare, spiegare, rispondere.
Ma bisognerebbe che anche gli adulti, forse loro per
primi, facessero un corso di educazione sessuale.
domenica 25 dicembre 2011
Amicizie e feste
Nei giorni di festa si incontrano gli amici, si scambiano i regali, ci si fanno gli auguri. Si riflette sulle amicizie che rimangono e su quelle che passano e su cosa significa essere amici.
Mia figlia adolescente mi parla spesso delle sue amiche, me ne parla quasi più che del suo ragazzo. Ha con le amiche e con qualcuna in particolare dei rapporti molto profondi ed a volte contrastati. Anche la piccola può star male e soffrire delle relazioni di amicizia. Una volta si è messa a piangere per un litigio con una amica, che le aveva negato all'improvviso un quaderno sul quale insieme scrivevano racconti.
Nella mia vita le amiche ricoprono un posto importante. Ce ne sono alcune con le quali ho condiviso quasi una vita intera. Da bambine mi hanno accompagnato a danza, mi hanno incontrato alle scuole medie, sono state mie compagne al liceo e all'università, per qualche tempo siamo state anche lontane, distanti. Poi ci siamo ritrovate, cambiate ed abbiamo continuato a crescere insieme. Sono quei rapporti che diventano come un albero, che cresce accanto a te e cambia, può perdere le foglie, può perdere i colori, ma poi li ritrova ed è ancora vivo, proprio lì, vicino a te.
Queste sono le amiche che sono presenti ad ogni Natale, che trovano comunque il modo di salutarti e che sanno quale regalo farti, anche se ne hanno già fatti tanti.
Poi ci sono altre amicizie che somigliano a comete, brevi e intense, rapporti che si bruciano in poche situazioni, in qualche mese. Sono quelle che hanno una intensità particolare e che fanno quasi sentire innamorati, ma poi improvvisamente spariscono nel nulla per incomprensioni non chiarite o offese mai confessate. Sono le amiche che mancano nei giorni di festa, sono quelle che ci si chiede cosa stiano facendo, cosa stiano pensando, cosa abbiamo fatto per offenderle oppure perchè ci hanno offeso e ferito.
Oppure ci sono rapporti che sono legati ai contesti, al lavoro, ad un corso di formazione, ad una vacanza, e che durano il tempo di quella coincidenza, con lealtà e anche profondità, ma che poi, una volta che il contesto cambia, sbiadiscono e si allentano. Però durante le feste si manda un messaggio, un sms o una email, così, tanto per tenersi in contatto, tanto per dirsi che quello che c'è stato non è stato futile.
Poi ci sono le amicizie nuove, quelle che hanno pochi anni di storia, le amicizie da adulti, che non sono come quelle "storiche", assomigliano a piante da appartamento, fedeli e presenti, che vanno coltivate quotidianamente e curate con attenzioni speciali, ma che sanno dare conforto e compagnia. Sone le amicizie che possono ancora sorprendere, ma che già si sa che dureranno, che ci accompagneranno ancora. Sono le amiche con cui si passano le feste, si organizza una cena o un pomeriggio per fare due chiacchiere.
Oggi poi ci sono anche le amicizie sui social network, quelle che si creano per la condivisione di pochi interessi o di amici in comune, amicizie virtuali, perchè spesso legate a poche frasi o commenti, ma non insignificanti, mai inutili. Con loro ovviamente ci si scambia auguri virtuali e qualche immagine divertente e si spera prima o poi di incontrarsi di persona, oppure no, perchè non è detto che sia meglio.
Tanti auguri anche ai miei lettori.
(Chissà se sono solo i miei amici, oppure se con qualcuno di loro potrei anche diventare amica....:))
Mia figlia adolescente mi parla spesso delle sue amiche, me ne parla quasi più che del suo ragazzo. Ha con le amiche e con qualcuna in particolare dei rapporti molto profondi ed a volte contrastati. Anche la piccola può star male e soffrire delle relazioni di amicizia. Una volta si è messa a piangere per un litigio con una amica, che le aveva negato all'improvviso un quaderno sul quale insieme scrivevano racconti.
Nella mia vita le amiche ricoprono un posto importante. Ce ne sono alcune con le quali ho condiviso quasi una vita intera. Da bambine mi hanno accompagnato a danza, mi hanno incontrato alle scuole medie, sono state mie compagne al liceo e all'università, per qualche tempo siamo state anche lontane, distanti. Poi ci siamo ritrovate, cambiate ed abbiamo continuato a crescere insieme. Sono quei rapporti che diventano come un albero, che cresce accanto a te e cambia, può perdere le foglie, può perdere i colori, ma poi li ritrova ed è ancora vivo, proprio lì, vicino a te.
Queste sono le amiche che sono presenti ad ogni Natale, che trovano comunque il modo di salutarti e che sanno quale regalo farti, anche se ne hanno già fatti tanti.
Poi ci sono altre amicizie che somigliano a comete, brevi e intense, rapporti che si bruciano in poche situazioni, in qualche mese. Sono quelle che hanno una intensità particolare e che fanno quasi sentire innamorati, ma poi improvvisamente spariscono nel nulla per incomprensioni non chiarite o offese mai confessate. Sono le amiche che mancano nei giorni di festa, sono quelle che ci si chiede cosa stiano facendo, cosa stiano pensando, cosa abbiamo fatto per offenderle oppure perchè ci hanno offeso e ferito.
Oppure ci sono rapporti che sono legati ai contesti, al lavoro, ad un corso di formazione, ad una vacanza, e che durano il tempo di quella coincidenza, con lealtà e anche profondità, ma che poi, una volta che il contesto cambia, sbiadiscono e si allentano. Però durante le feste si manda un messaggio, un sms o una email, così, tanto per tenersi in contatto, tanto per dirsi che quello che c'è stato non è stato futile.
Poi ci sono le amicizie nuove, quelle che hanno pochi anni di storia, le amicizie da adulti, che non sono come quelle "storiche", assomigliano a piante da appartamento, fedeli e presenti, che vanno coltivate quotidianamente e curate con attenzioni speciali, ma che sanno dare conforto e compagnia. Sone le amicizie che possono ancora sorprendere, ma che già si sa che dureranno, che ci accompagneranno ancora. Sono le amiche con cui si passano le feste, si organizza una cena o un pomeriggio per fare due chiacchiere.
Oggi poi ci sono anche le amicizie sui social network, quelle che si creano per la condivisione di pochi interessi o di amici in comune, amicizie virtuali, perchè spesso legate a poche frasi o commenti, ma non insignificanti, mai inutili. Con loro ovviamente ci si scambia auguri virtuali e qualche immagine divertente e si spera prima o poi di incontrarsi di persona, oppure no, perchè non è detto che sia meglio.
Tanti auguri anche ai miei lettori.
(Chissà se sono solo i miei amici, oppure se con qualcuno di loro potrei anche diventare amica....:))
domenica 11 dicembre 2011
Una sessualità consapevole?
Oggi sul giornale c'erano due notizie che riguardavano due adolescenti di sedici anni. Una ragazza voleva tenere il figlio che aveva avuto con il suo ragazzo albanese, ma i genitori non erano d'accordo e si erano rivolti al giudice del Tribunale per i minorenni. Ovviamente il giudice non poteva imporle nulla, la legge anzi a questa età tutela le ragazze che rimangono in stato interessante nella loro autonomia, sia di abortire, che di tenere un figlio. Sembra che però dopo un colloquio con il giudice la ragazza abbia deciso di seguire le indicazioni dei genitori.
C'era poi nelle pagine seguenti un'altra notizia che riguardava sempre una sedicenne. Questa volta la ragazza aveva raccontato di essere stata violentata da alcuni stranieri e questo racconto aveva addirittura provocato una protesta da parte dei suoi concittadini che si è drammaticamente conclusa con l'assalto, da parte di alcuni, ad un campo rom. Peccato che la ragazza sembra aver raccontato l'episodio della violenza per coprire un rapporto sessuale consensuale che si vergognava di spiegare ai suoi genitori.http://www.unita.it/italia/stupro-a-torino-bruciate-baracche-rom-1.361338
In entrambi i casi il punto mi sembra essere che se è vero che abbiamo superato diversi tabù relativi al sesso e questo è stato sicuramente un bene, non riusciamo comunque a preparare i ragazzi ad una vita sessuale consapevole.
Mi sono ricordata di aver parlato qualche giorno fa con le mie figlie di aborto e della responsabilità che è legata ai rapporti sessuali. A volte mi sembra di trattarle come delle adulte e di pretendere un po' troppo da loro, ma oggi dopo aver letto queste notizie mi sono detta che è importante continuare a farlo.
Anche se non è facile spiegare e preparare i figli ad un rapporto sereno e responsabile con il sesso, è importante comunque provarci. Non è una garanzia che non succedano certe situazioni, certo, ma le rende meno probabili.
Nella discussione con le mie figlie mi aveva colpito la loro certezza che non avrebbero abortito, il rifiuto totale di prendere in considerazione l'idea. Posso capire che l'idea della morte di un bambino per loro possa essere davvero difficile da capire e da accettare, come deve esserlo stato per la ragazza che aveva scelto di tenere il figlio avuto da una relazione che per lei evidentemente era importante.
Per questo certe decisioni non dovrebbero mai essere prese, almeno non a questa età, si dovrebbe cercare il più possibile di evitare di trovarsi a prenderle.
Per evitare di trovarsi a scegliere sarebbe importante informare meglio i ragazzi, dar loro la possibilità di comprare preservativi o di avere contraccettivi facilmente reperibili, di fare "educazione sessuale" e non solo "educazione alla affettività".
Invece nelle scuole superiori si dà per scontato che i ragazzi sappiano tutto sul sesso e non ci si pone il problema di discutere con loro quando, come fare sesso, quali sono le conseguenze sulla loro vita di un momento in cui si è fatto sesso con superficialità. Perchè ad esempio non si prendono i casi della cronaca, come quelli che ho letto oggi e si discutono con i ragazzi? Perchè gli insegnanti non si sentono più autorizzati a farlo? Lo fanno i genitori?
Credo che ci siano molte madri che ci pensano e che ci provano, come sto facendo io. Spero che lo facciano anche i padri con i figli, questo non lo so bene, trovo difficile che sia frequente.
Oggi c'è stata anche la manifestazione del movimento "Se non ora quando", stimolata dalle misure del governo Monti che colpiscono profondamente le donne. Siamo in prima linea perchè vengono colpite ancora le pensioni delle donne, che da sempre fanno un doppio lavoro: in casa e fuori.http://www.unita.it/donne
C'è bisogno che le donne tornino a mobilitarsi e c'è bisogno che torniamo a discutere anche di come educare a una sessualità maggiormente consapevole, perchè poi il peso di certe scelte, o non-scelte, ricade soprattutto sulle donne, sulle nostre figlie, su noi come madri.
C'era poi nelle pagine seguenti un'altra notizia che riguardava sempre una sedicenne. Questa volta la ragazza aveva raccontato di essere stata violentata da alcuni stranieri e questo racconto aveva addirittura provocato una protesta da parte dei suoi concittadini che si è drammaticamente conclusa con l'assalto, da parte di alcuni, ad un campo rom. Peccato che la ragazza sembra aver raccontato l'episodio della violenza per coprire un rapporto sessuale consensuale che si vergognava di spiegare ai suoi genitori.http://www.unita.it/italia/stupro-a-torino-bruciate-baracche-rom-1.361338
In entrambi i casi il punto mi sembra essere che se è vero che abbiamo superato diversi tabù relativi al sesso e questo è stato sicuramente un bene, non riusciamo comunque a preparare i ragazzi ad una vita sessuale consapevole.
Mi sono ricordata di aver parlato qualche giorno fa con le mie figlie di aborto e della responsabilità che è legata ai rapporti sessuali. A volte mi sembra di trattarle come delle adulte e di pretendere un po' troppo da loro, ma oggi dopo aver letto queste notizie mi sono detta che è importante continuare a farlo.
Anche se non è facile spiegare e preparare i figli ad un rapporto sereno e responsabile con il sesso, è importante comunque provarci. Non è una garanzia che non succedano certe situazioni, certo, ma le rende meno probabili.
Nella discussione con le mie figlie mi aveva colpito la loro certezza che non avrebbero abortito, il rifiuto totale di prendere in considerazione l'idea. Posso capire che l'idea della morte di un bambino per loro possa essere davvero difficile da capire e da accettare, come deve esserlo stato per la ragazza che aveva scelto di tenere il figlio avuto da una relazione che per lei evidentemente era importante.
Per questo certe decisioni non dovrebbero mai essere prese, almeno non a questa età, si dovrebbe cercare il più possibile di evitare di trovarsi a prenderle.
Per evitare di trovarsi a scegliere sarebbe importante informare meglio i ragazzi, dar loro la possibilità di comprare preservativi o di avere contraccettivi facilmente reperibili, di fare "educazione sessuale" e non solo "educazione alla affettività".
Invece nelle scuole superiori si dà per scontato che i ragazzi sappiano tutto sul sesso e non ci si pone il problema di discutere con loro quando, come fare sesso, quali sono le conseguenze sulla loro vita di un momento in cui si è fatto sesso con superficialità. Perchè ad esempio non si prendono i casi della cronaca, come quelli che ho letto oggi e si discutono con i ragazzi? Perchè gli insegnanti non si sentono più autorizzati a farlo? Lo fanno i genitori?
Credo che ci siano molte madri che ci pensano e che ci provano, come sto facendo io. Spero che lo facciano anche i padri con i figli, questo non lo so bene, trovo difficile che sia frequente.
Oggi c'è stata anche la manifestazione del movimento "Se non ora quando", stimolata dalle misure del governo Monti che colpiscono profondamente le donne. Siamo in prima linea perchè vengono colpite ancora le pensioni delle donne, che da sempre fanno un doppio lavoro: in casa e fuori.http://www.unita.it/donne
C'è bisogno che le donne tornino a mobilitarsi e c'è bisogno che torniamo a discutere anche di come educare a una sessualità maggiormente consapevole, perchè poi il peso di certe scelte, o non-scelte, ricade soprattutto sulle donne, sulle nostre figlie, su noi come madri.
giovedì 17 novembre 2011
Ci sono giornate nelle quali mi sento stanca del mio lavoro. Sono momenti nei quali tutto sembra faticoso e complicato. Arrivano telefonate e segnalazioni di casi nuovi. Incontro genitori tristi o arrabbiati o scoraggiati e bambini soli con le loro paure e incapacità.
Mi chiedo come posso aiutarli e perchè ho scelto proprio questo lavoro.
Mi chiedo come posso aiutarli e perchè ho scelto proprio questo lavoro.
Perché lavoro con i bambini?
Posso dire che ho scelto progressivamente ciò in cui mi sono trovata.
Quando ho vinto il concorso per psicologa nella USL mi hanno assegnato il settore dell'intervento in età evolutiva. Il lavoro con i bambini e gli adolescenti mi ha coinvolto subito per i suoi aspetti molteplici e complessi.
Non è possibile interessarsi di infanzia e adolescenza senza occuparsi di genitori e di insegnanti e progressivamente di comunità allargate.
I bambini vivono con noi, non vengono da soli ai nostri servizi, non chiedono aiuto solo per se stessi, spesso il loro disagio è quello di una intera famiglia, di una intera classe scolastica, se non addirittura di una intera società.
Qualche tempo fa è successo un episodio che ha portato prepotentemente alla ribalta il modo in cui questa società si rapporta all'”Altro”, rappresentato dal bambino così come dal diverso handicappato.
In un video registrato da un alunno e pubblicato impunemente su Youtube, come fosse assolutamente normale, una intera classe sbeffeggiava, offendeva e picchiava un ragazzo Down.
E' un episodio nel quale significativamente erano minori sia i violenti che i violentati.
E' qualcosa che ci dovrebbe fare riflettere più profondamente dello scandalo immediato che ha suscitato.
Il problema non è solo indignarsi perchè una persona viene maltrattata, il problema che dovrebbe tutti coinvolgerci è rappresentato dai ragazzi che insieme, senza voci contrarie, mettono in atto quella violenza e la pubblicano come un trofeo.
Come è possibile che in una società che ha scelto l'integrazione dei ragazzi diversamente abili all'interno delle scuole, che difende la scelta di non segregazione in scuole speciali, non sia ancora cresciuta una cultura di sensibilità e solidarietà con l'handicap? Come è possibile, più profondamente, che il bullismo sia un fenomeno così prepotentemente emergente?
Il bullismo è la perversione della forza, la caricatura della autorità ed è il frutto di una società confusa rispetto ai propri modelli educativi.
Per questo si parla molto di genitorialità, ci sono corsi e seminari rivolti ai genitori, si delega agli esperti il ruolo di educatori e alla fine i servizi per l'infanzia sono pieni di genitori in crisi e di bambini in difficoltà.
Perchè quindi lavoro con i bambini?
Forse perchè la loro sofferenza mi appare più ingiusta di quella di un adulto, perchè carica di variabili sulle quali i bambini hanno la minore incidenza possibile.
Per un adulto spesso esiste almeno una possibilità di scelta nelle condizioni nelle quali vive.
Per un bambino la stessa possibilità di scegliere non è prevista.
E' questa ingiustizia che mi fa continuare a scegliere i bambini.
Voglio dare loro un'altra possibilità.
A volte quando il lavoro va bene, ho l'impressione di riparare almeno in parte ad una ingiustizia, sia essa della natura o della società o della famiglia.
E' una motivazione forte, ancora ora, nonostante diciotto anni di incidenti e scogli e lentezze e ingiustizie del lavoro nella ASL.
Iscriviti a:
Post (Atom)